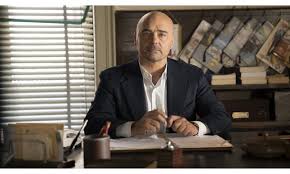La 4M e la 4N nel gran Milano! (4 puntata)
Sembra che siano passate ere geologiche e che allora scorrazzassero per Milano i dinosauri, ma neanche un anno fa, io e i miei studenti di 4M (ora 5M), cui si erano aggregati quelli dell’attuale 5N, con l’amabile e sollecito sostegno delle colleghe Beatrice (Latino) e Marilena (Religione), eravamo in viaggio d’istruzione a Milano: una Milano ben diversa da quella silente di adesso, degna dell’antico “Intervallo” (con la musichetta di sottofondo). Anche se l’atmosfera ora è drammatica, per non dire molto, ma molto grave, riprendo qui, dopo lunga pausa, la mia “epopea” della gita a Milano dell’anno scorso per tirare su il morale di tutta la mia platea: sono sicura che ce n’è bisogno. Quindi, rieccoci qui, io, le colleghe e i miei studenti, in vena di ricordi, per di più ricordi che riguardano proprio il capoluogo della Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia. Che i ricordi siano piacevoli (specie quando dilaga la preoccupazione, si è rintanati a casa e, a parte la vita normale, sono saltate inesorabilmente più o meno una dozzina di gite) me lo dice il fatto che, qualche giorno fa, circolava sulla nostra chat interna di 5M un video proprio di una di quelle sere, quella fatidica del giovedì 20 marzo in cui siamo usciti fuori. Ma procediamo con ordine.
Se non erro, alla
fine della terza puntata avevo lasciato il mio pubblico in sospeso (suspence…)
con la questione fatidica del “bosco verticale”. Lo avremmo o non lo avremmo
visitato? Posso affermare che ormai, il giovedì, la questione era diventata un
vero e proprio “tormentone”. La sera del mercoledì votammo democraticamente la
richiesta di andare a visitare i due grattacieli e ci furono solo 5-6 voti
favorevoli (manco a dirlo, aveva votato così compatto il tavolo di Chiara di
4N, che proponeva la cosa con notevole…tenacia; e ciò mi fece supporre un’opera
di convincimento, da parte della suddetta nei confronti delle sue amiche,
paragonabile, minimo minimo, agli argomenti impiegati da Carlo Magno per convertire
i Sassoni al cristianesimo…). Però, il soggetto riemergeva in continuazione. E
così, il mercoledì ci ritrovammo a discutere a cena con l’autista su come
includere la panoramica dei due famosi grattacieli nel nostro giro – e non c’era
verso, comunque la mettessimo, o che li raggiungessimo a piedi, o che
obbligassimo il pullman a un giro inverosimile fino alla zona Isola, dovevamo
sforare ampiamente con il programma. Poi, il giovedì, praticamente mi ritrovavo
la questione sotto al naso ad ogni pie’ sospinto: anche perché, ad ogni pie’
sospinto, Chiara veniva a ricordarmela con ammirevole costanza.
Alla fine, quando nel pomeriggio fu
annunciata l’ora libera per il giretto in centro, con un brusco voltafaccia
Chiara fu abbandonata in tronco dalle sue amiche, che, in modo molto femminile,
considerarono le vetrine molto più attraenti di quel che ormai Marilena
definiva semplicemente come “due palazzi con degli alberi sopra”. Questa
definizione potrà apparire eretica ai fans dello studio che ha progettato
(con molta fatica e attenzione per i dettagli, bisogna dirlo) i suddetti
grattacieli: però non è così fuori luogo come sembra, dato che, se girate per
Milano, vi renderete conto che i giardini pensili sono una caratteristica della
città, per cui il “bosco verticale” ha semplicemente ripreso in grande stile
una consuetudine cittadina. Alla fine, Chiara, abbandonata “ignominiosamente” dalle
sue amiche e avvertita da Marilena che proprio non riuscivamo a spostarci fin
là, zitta zitta, approfittando del fatto che era già maggiorenne, ci è
sgusciata via di soppiatto ed è andata in metro fino ai suddetti grattacieli,
dove ha scattato fotografie a volontà. In seguito ci ha riportato notizie sulle
cifre di affitto di un appartamento nei due edifici, notizie tali da sfidare
ogni comune buon senso, ma ormai era contenta ed appagata. Al termine della
giornata, sulla via dell’albergo, l’autista è infine passato davanti ai due
grattacieli, così vissero tutti felici e contenti.
Ma il grande momento
del giovedì è stata l’uscita serale. E qui casca l’asino. Dovete sapere che
l’uscita serale è il culmine delle preoccupazioni degli studenti in gita: e,
per tutt’altri motivi, comprensibilmente, dei professori in gita.
Allora, fin da quando, a gennaio 2019, al Roiti avevano cominciato a filtrare
notizie su questo viaggio d’istruzione, sia nella mia classe, sia quando
incrociavo qualche elemento rappresentativo della 5N per il corridoio della
succursale, regolarmente venivo subissata di domande. Però: non è che ti
vengono a chiedere, che so, le condizioni dell’assicurazione in caso di
disdetta, oppure (il che sarebbe encomiabile) il regolamento interno
dell’albergo dove pernotteremo; non si preoccupano (loro) delle norme di
sicurezza da seguire in pullman oppure dell’organizzazione del programma, della
logistica, delle spese, delle scadenze di pagamento ecc. ecc. ecc. NO. Loro
mi ripetono sempre e solo due domande fatidiche:
1) “Andremo
a fare shopping in centro?” (domanda squisitamente femminile e che, devo
ammettere, riguarda per lo più solo la parte, appunto, femminile delle classi).
2) (E
questa è invece la domanda, più insidiosa, quella che mi ripetono come un giradischi rotto tutti, ma
proprio tutti, almeno da tre mesi prima) “Usciremo la sera?” – anzi no:
“Prooof?! – con tre “o” e la vocetta melliflua – “Usciremo fuori la sera?”.
Quanto alla domanda
n°1, ho ottemperato (si veda sopra) e la messa in pratica è senza storia: il
giovedì pomeriggio, dopo la sosta al planetario, concessi poco più di un’ora
libera in centro. Certo, guardare le vetrine piace anche a me ed alle colleghe:
comunque, a quel punto si svegliarono tutti (anche e in special modo quelli/e
che si erano pacificamente addormentati/e sotto le stelle del planetario).
Quanto alla domanda
n°2, devo fare una premessa per chi ignora le condizioni di lavoro di noi
docenti (e al prossimo che mi obietta che noi non lavoriamo abbastanza, gli
cedo gratis il posto di capogruppo della prossima gita). L’incubo di ogni
insegnante che si rispetti è che gli studenti rientrino in albergo la sera con
energie sufficienti per passare la notte in giro come i vampiri: e vi posso
assicurare che l’aglio non basta a fermarli. Un capogruppo, sempre uno che si
rispetti, sa qual è la priorità assoluta: DISTRUGGERLI. Cioè, il programma deve
essere abbastanza intenso e carico da stancarli a dovere, in modo che, poco
prima di andare a dormire, siano cotti a puntino e CROLLINO. Come pere cotte. Mi
fregio del fatto che questa misura sia stata approvata solennemente anche da
qualche collega piuttosto assennata. Ve lo assicuro, in assenza di aglio a
volontà, è l’unica misura preventiva contro i miei emuli di Twilight:
lungi da me l’aspettare l’alba perché si dissolvano al primo raggio di sole
(!); e, nonostante i miei trascorsi pastorali, confermo che neanche le croci
bastano contro certe attività notturne. Anzi.
Ora, qualcuno
ricorderà che, la prima sera, dopo cena, nella sezione appartata del ristorante
dove eravamo stati allocati, io avevo proceduto, democraticamente, a una
votazione; e avevo posto due quesiti: quello sul famoso (ormai famigerato)
“Bosco verticale”; e uno su quanti volevano fare la passeggiata serale. Del
risultato della prima votazione ho già detto: quanto alla seconda, se non
ricordo male i miei giovanotti optarono all’unanimità per l’uscita serale. Ci
tengo a ricordarlo a scanso di equivoci: e dato che il seguito potrebbe essere
frainteso da qualcuno come un accesso di manie dittatoriali, che neanche il
Ventennio, io sottolineo che avevo proceduto a una votazione democraticamente
intesa. Ora, intendiamoci: la scuola non è una democrazia (anzi: e guai se lo
fosse!). E’ una struttura ispirata a principi democratici e in cui i soggetti
che ancora stanno imparando a governarsi da soli, godono di ampie
rappresentanze (per quanto, alle volte, e specie con certuni, io nutra il fondato
dubbio che i bambini dell’asilo - nido di fronte al Roiti espletino questi
gravi compiti con maggiore consapevolezza…). Tuttavia, avevano votato. E
volevano uscire la sera del giovedì. Era ufficiale.
Ebbene, anche se, ad
essere onesti, dopo il coprifuoco del mercoledì sera io non avevo più sentito
una mosca volare ed erano tutti tranquilli (almeno esternamente), di certo,
dentro le stanze si erano dati ai bollenti spiriti e alla pazza gioia: e
qualcuno doveva avere fatto l’alba non a fare chissà che, ma semplicemente a
chiacchierare. Risultato: il giorno dopo cominciò a serpeggiare tra le mie
truppe uno strano malcontento: alcuni, che cominciavano a trascinare i piedi
dalla stanchezza (!), avrebbero voluto evitare l’uscita serale e ritirarsi in
albergo all’ora delle galline. E qui le colleghe furono ferree: no,
assolutamente no (sennò, come già detto, ce li saremmo ritrovati a girare la
notte per i corridoi con una verve che neanche Dracula nel suo castello
in Transilvania!); o tutti dentro, o tutti fuori. E, dato che avevamo votato
per uscire fuori, saremmo usciti fuori. TUTTI.
A questo punto
cominciarono le varianti delle lamentele: e a me sembrava di essere Mosé nel
deserto, con gli Ebrei a cui non ne andava bene una. “Prooof!” (sempre con 3
“o”) “Rifacciamo la votazione???”; “Prooof? Possiamo restare a casa stasera?”
“Prooof! Non ce la facciamo più!” e via dicendo. E io irremovibile. Divenni
inflessibile, scultorea come una statua di marmo: anche perché conosco i miei
polli e il mio pollaio e sapevo in anticipo come sarebbe andata a finire (…).
Quanto poi a ripetere la votazione – e ancora ricordo Francesco P., un
bravissimo ragazzo di 5N che adesso mi saluta sempre, quando mi incrocia, ma che
quel giorno tirava fuori ‘sta storia ripetutamente e procedeva con la stessa verve
di una lumaca e più o meno ormai al livello del manto stradale -, dicevo,
quanto a ripetere la votazione, NO. Mica siamo come gli Inglesi della Brexit, che,
ogni tanto, ritiravano fuori la storia della votazione per ripeterla finché non
ne sarebbe uscito il risultato che volevano loro! E qui mi sento di spezzare
una lancia per Juncker. Per motivi squisitamente personali, che il poveretto
ignora e che è inutile io dettagli qui, io non provo grande simpatia per
l’ex – presidente della Commissione Europea: però, a un certo punto, mi faceva
quasi compassione. Anche io stavo facendo la sua esperienza e mi sentivo di
comprenderlo e di posargli una mano sulla spalla con genuina simpatia: “Jean –
Claude! Ti capisco, oh, come ti capisco!... Tu hai a che fare con gl’Inglesi,
che ancora non hanno deciso che cosa vogliono: e verrebbe da dire loro, come i
Romani ad Asterix: “Decidetevi! O dentro, o fuori! Però basta picchiarci!”; mentre
io invece, guarda qui! Nel mio piccolo, ho sotto di me una banda di una
cinquantina di adolescenti, con la sindrome della banderuola. E anche loro
vogliono votare in continuazione! Mah!”
Il picco delle lamentele
arrivò poco dopo che avevamo visto dal pullman il Bosco verticale ed eravamo
sulla strada di casa: sembrava che fossero tutti (o quasi) moribondi ed era ormai
un coro di lamenti. E io al microfono:
- E’ da gennaio che
appena possibile mi venite a chiedere: “Prooof” – sempre con 3 “o” e la vocetta
melliflua che contraffaceva la loro – “Usciremo la sera?”; e adesso che è
venuto il momento, stasera usciamo! Tutti quanti!- .
Inutile dire che le colleghe,
per motivi disciplinari, peroravano la questione del blocco unico. Senonché –
succede, sempre, dico SEMPRE così – qualcosa andò storto: uno dei nostri ebbe
una crisi di mal di stomaco dopo cena. Ovviamente, eravamo preoccupate e per
lui (non dirò chi era il poveretto, ma stava veramente male), e anche per la
nostra coerenza disciplinare: non c’è niente di più pericoloso, per un
insegnante, che dare un ordine e poi dovere rimangiarselo. E quindi….
E quindi vi lascio nella
suspence fino alla prossima puntata. Se la caveranno tre insegnanti di
buona volontà in missione con una cinquantina di adolescenti in vena di
lamentele e di sedizione?
PS. Vi lascio solo
una breve anticipazione: il motto del seguito sarà Avanti, Savoia!