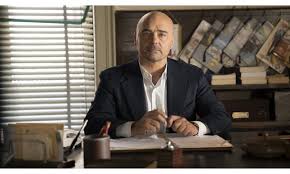Napoleon (R.Scott, 2023)
Ne hanno parlato tutti, ma proprio tutti, per cui io arrivo qui come il fanalino di coda a dare il mio contributo (modesto) e il mio parere su questo film attesissimo, fischiato da tutte le parti, specie (e non solo) dagli storici, ma che comunque rimane l'opera di un gran cineasta: e sì, secondo me avrebbe potuto essere un gran bel film, se solo....
Ma andiamo con ordine. Quasi nessuno accenna mai ai lati positivi del film Napoleon, il kolossal da 2 ore e mezzo dedicato da Ridley Scott alla vita di Napoleone Bonaparte, ma in realtà i lati postivi ci sono e proprio dal punto di vista cinematografico. La parte migliore della pellicola è proprio quella tecnica: fotografia, scenografie, costumi; la ricostruzione dell'ambiente fine Settecento, inizi Ottocento è infatti di pregio e molte scene ricordano quadri. Si può discutere a non finire sugli errori storici della pellicola, ma indubbiamente, la presa di Tolone, l'episodio che consacra Bonaparte generale e lo proietta alla ribalta della vita politica e militare francese, oppure la stessa battaglia di Austerlitz, per quanto ricostruita in maniera errata, o l'imponente incoronazione (che riprende il celebre quadro di David), o anche certe scene di interni, come le feste di Joséphine, sembrano dei quadri coevi (e sicuramente li riprendono). Certo, anche in questo campo non manca qualche errore: per esempio, la casa di Joséphine, visibilmente, non è la celeberrima Malmaison, ma una villa inglese. Tuttavia, Napoleon è innanzitutto un film molto bello da vedere e che immerge in un' ambiance d'epoca riuscita; e questo anche se qua e là compaiono errori vistosi (come il famoso mirino sul fucile). Devo ammettere che, preparata da una marea di recensioni negative non me lo aspettavo e, nonostante tutto, sono uscita dal cinema, almeno su questo, piacevolmente sorpresa.
Tuttavia, non si possono ignorare gli errori storici macroscopici (anche se mi sembra che su Youtube parecchi si siano improvvisati storici per l'occasione). E' perfettamente vero che abbondano: manca del tutto la campagna d'Italia, che ha consacrato Napoleone; la scena della battaglia delle Piramidi in cui vengono bombardate le piramidi stesse fa ridere i polli; Austerlitz, forse la più grande vittoria dell'imperatore, è completamente sballata, dato che non fu combattuta né in pianura, né sul ghiaccio, bensì Napoleone ebbe l'astuzia di attirare gli Austro-Russi nella nebbia del fondo valle per poi impadronirsi delle alture (da leggere assolutamente al riguardo la prima parte di Guerra e pace di Lev Tolstoj, la cui ricostruzione è accuratissima). Forse proprio perché è inglese, Scott si è difeso meglio nelle scene finali sulla battaglia di Waterloo: e si potrebbe continuare così per un pezzo. Però, a mio avviso, dato che questo è un film e non un documentario, gli errori singoli, circoscritti, ancorché gravi, possono dare meno fastidio di quanto si pensi: tutto sommato, se la parte tecnica e cinematografica, se la ricostruzione d'ambiente è credibile, passino anche certi errori specifici. Posso anche accettare che Napoleone sia presente alla decapitazione di Maria Antonietta - e per di più le hanno lasciato i capelli lunghi - se però questo si amalgama bene con il senso del film; e, in effetti, si potrebbe osservare che magari "idealmente" vi era presente; oppure, la resa artistica della battaglia di Austerlitz (con le trincee! Degne della I Guerra Mondiale), che trasforma in una scena impressionante e catastrofica un singolo episodio, cioè il fatto che alcuni Russi si siano avventurati sul lago ghiacciato formato da una diga, possiede comunque una riuscita indubbia.
Molti recensori si sono focalizzati sugli errori richiamati sopra e, tutto sommato, circoscritti ancorché grossolani. Il peggio però è altrove. Il vero problema di Napoleon consiste nella sua impostazione: per esempio, mi pare molto più grave che manchi del tutto la resa del gruppo di generali, da Murat a Bernadotte, passando per Masséna, Ney, Noailles, Joubert, Labadie (e si potrebbe andare avanti per un pezzo), generali che hanno combattuto con e per Napoleone: perché la vita militare è soprattutto vita di squadra, di corpo e tra questi generali c'era una comunione di intenti e un cameratismo di grande afflato per un film. Ricordo al confronto le scene in cui Christian Clavier, interprete della serie francese Napoléon del 2002, annunciava che la Grande Armata si metteva in marcia: tutt'un altro carisma. Allo stesso modo, mi sembra lamentabile che una sola scena venga dedicata alla popolarità dell'imperatore tra le sue truppe. Napoleone era Napoleone anche e soprattutto perché sapeva guadagnarsi la stima dei suoi soldati: e lo faceva passeggiando tra i bivacchi, all'incerta luce dei fuochi da campo, magari sedendosi accanto ai suoi sottufficiali e ricordando le grandi battaglie del suo passato: Marengo, Friedland, Wagram, Austerlitz, Eylau...Tutto questo manca, il che è dovuto sicuramente a una scelta precisa di Scott e del suo sceneggiatore David Scarpa (a meno che non compaia nella parte tagliata: il regista ha promesso la messa in commercio di una versione con director's cut da 4 ore e sono curiosa di scoprire che cosa ci si trovi di quello di cui lamento io qui la mancanza).
Jean Tulard, in assoluto il maggiore storico di Napoleone vivente e, tra l'altro, appassionato di cinema, ha indicato poi un altro difetto vistoso della messa in scena: Joaquim Phoenix, l'attore protagonista, non cambia mai nel corso della vicenda ed è sempre lo stesso da Tolone a S.Elena, senza ingrigire o incicciottire nemmeno un po' (alla fine della sua vita, l'imperatore era decisamente meno snello che a Tolone, agli esordi della sua carriera). Potrei portare anche altri esempi, ma quanto ho finora indicato rivela qual è il problema fondamentale del film: l'impostazione di base. Si è detto che il film è concentrato sulla storia d'amore tra Napoleone e Joséphine e in effetti sembra che quello sia il taglio della vicenda, ma la cosa non mi convince; è vero che il protagonista compie delle sciocchezze inenarrabili per tornare da Joséphine (come abbandonare la campagna d'Egitto, un errore gravissimo della sceneggiatura, a mio modesto avviso), ma la storia "d'amore" è spesso descritta in toni a dir poco indecenti, nonostante che manchino delle scene in deshabillé; sembra riprendere un po' di dignità solo verso la fine. Capisco che le lettere della coppia erano spesso torride, però la selezione delle stesse poteva essere operata con intenti diversi: qui sembra che si voglia denigrare il più possibile la loro storia. Tra l'altro, pare che gli attori stessi, trascinati dal modus operandi di Scott, abbiano aggiunto delle scene di loro gusto, come lo schiaffo di Napoleone alla moglie (???).
E qui arriviamo al punto cruciale della questione: qual è il ritratto che Ridley Scott voleva offrire di Napoleone? Qualcuno ha osservato che non sia affatto vero che Scott, da Inglese, volesse sminuire l'imperatore francese: e allora mi chiedo: ah noo? Perché, onestamente, mi pare che Scott abbia voluto presentare proprio un Napoleone grottesco, per nulla credibile. Certo, Ridley Scott possiede una sensibilità speciale per il grottesco, una delle sue cifre stilistiche. Però, diciamocela tutta: per la maggior parte delle scene del film, ci troviamo davanti un emerito cretino, che non sa neanche come fare la corte a Joséphine, che se ne rimane rigido e impalato come un manico di scopa nella sua uniforme, seduto davanti a lei senza saper che dire (e questo danneggia irrimediabilmente anche la recitazione di Joaquim Phoenix, che poi non assomiglia neanche al personaggio). E poi, quando si inseguono giocando a nascondino sotto il tavolo, oppure si tirano dei pezzi di cibo nel bel mezzo di un pranzo di famiglia...Ma c'è veramente bisogno di ritrarre un personaggio storico così? Dove sono le sue capacità strategiche? E l'ambizione con cui è arrivato dove è arrivato: Tutto ei provò, la gloria, maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la reggia e il triste esiglio: due volte nella polvere, due volte sull'altar. Così si esprimeva Manzoni, che, pur non essendo un entusiasta pro-napoleonico, sapeva però riconoscere il fascino esercitato dal personaggio e la sua grandezza: l'Ottocento ha conosciuto una fittissima letteratura pro e contro Napoleone, con i Tedeschi che lo vedevano quale un orco e gli altri che lo osannavano, proprio perché era comunque un personaggio fuori dal comune. A buon diritto, Tulard osservava che se Napoleone ha entusiasmato i contemporanei e i posteri, ciò è avvenuto perché è stato l'eroe per eccellenza, quello che ha realizzato i sogni più impervi, partendo dal basso, dal suo ruolo di piccolo aristocratico di provincia, e conquistando l'Impero, su quasi tutta Europa. Di tutto questo nel film di Scott non c'è neanche l'ombra. Proprio Ridley Scott che sa essere così epico, poi rinuncia del tutto all'epica per scendere nel grottesco: si veda ad esempio il finale con la morte dell'ex-imperatore, un finale che fa cascare le braccia.
Certo, Napoleone può stare non solo antipatico, ma essere decisamente denigrato da chi appartiene alla parte avversa: fin dalle prime pagine di Guerra e pace Tolstoj (almeno attraverso la bocca dei suoi personaggi) lo qualifica come l'Anticristo e poi, in tutta una serie di scene che abbiamo analizzato con i miei studenti, lo descrive come il tipico tiranno, egocentrico, capriccioso, capace di ascoltare solo se stesso e di rinviare il povero Balasov, il rappresentante diplomatico russo, dopo non avergli lasciato praticamente spiccicare parola. Però, a parte il fatto che Tolstoj è ovviamente di gran lunga al di sopra di Ridley Scott, egli si può permettere questa descrizione negativa per due motivi di base: primo, è fedelissimo ai fatti e li ricostruisce con acribia di erudito, dopo aver condotto prolungate ricerche, quindi il suo Napoleone si vuole profondamente realistico; secondo, lo scrittore russo non sminuisce veramente l'imperatore, anzi, si rende perfettamente conto del pericolo che rappresenta. Intendo dire: non lo sottovaluta. E' un grande, ma un anticristo, un personaggio la cui volontà provoca tragedie e contro cui i Russi combattono letteralmente con le unghie e coi denti per difendere la loro patria fino all'ultimo respiro (vedere le pagine su Borodino al riguardo). Quello di Ridley Scott è invece, ripeto, un emerito cretino: e sono poche le scene in cui si salva (forse una è quella qui sotto, con Wellington, il suo vincitore di Waterloo).
In conclusione: la maggior parte dei recensori si sono concentrati sulle inesattezze, o sui grossolani errori storici; io mi scandalizzo molto di più per il quadro di insieme che è un vero e proprio tradimento della storia. Per questo ritengo che il film di Scott rappresenti un'ennesima forma di vendetta, la più perfida, degl'Inglesi contro l'Imperatore: non lo prende minimamente sul serio, anzi, lo presenta come un imbecille, uno che non è neanche in grado di fare la corte a sua moglie, che la insegue gattonando sotto il tavolo o che aspetta l'iniziativa di maman per avere un'amante e un figlio; per non parlare di quando abbandona le campagne militari per inseguire la fedifraga adultera. Così Napoleone sembra una marionetta e tutti coloro che hanno combattuto per o contro di lui niente di meno. Mi è venuto persino il dubbio che sotto sotto ci sia un po' dello spirito della Brexit (mah). Temo però che invece sotto ci sia lo spirito a dir poco molto disinvolto che negli ultimi decenni si è sviluppato contro la storia. La storia rappresenta il nostro principale termine di confronto per il presente: quando essa viene tradita in modo così clamoroso, la riflessione e l'insegnamento che ne possono emanare vanno del tutto perduti (come Cicerone sosteneva: Historia magistra vitae). E infatti, a parte le belle scene, non mi sembra che da questo film emerga alcun messaggio particolare (a differenza del Gladiatore, che invece possiede un suo significato, nonostante gli errori storici). Forse Scott (provo ad essere magnanima) voleva denigrare a priori la sete di potere e ridurne il suo latore al livello di una marionetta: però, onestamente, non si capisce. E' inutile poi che egli ripeta sprezzantemente ai suoi critici: "Fatevi una vita", quasi che fossero dei frustrati incapaci di comprendere l'arte o il linguaggio cinematografico. Non basta la forma: quando l'arte si svuota di contenuto, cosa rimane per le nostre giovani generazioni?
Per la mia recensione ho consultato le seguenti, che considero le più interessanti:
Napoléon: l'historien Jean Tulard analyse le film de Ridley Scott, Synopsis.média https://www.youtube.com/watch?v=_WSL9lhVsyA
Napoleon di Ridley Scott: un film indecente, un documento straordinario, Aldo Giannuli https://www.youtube.com/watch?v=VIA19HkL9nQ
La recensione di Giannuli è molto valida perché sottolinea la "svalutazione di ogni profondità culturale" tipica del modello hollywodiano (cui in fin dei conti anche Scott aderisce).
Napoleon di Ridley Scott, il film che aspettavamo o temevamo?, Pillole di storia. La biblioteca di Alessandria, https://www.youtube.com/watch?v=1H6RJznLaRw&t=156s
Napoleon di Ridley Scott è solo "propaganda femminista" e pro-inglese come dice qualcuno?, La biblioteca di Alessandria https://www.youtube.com/watch?v=8PikcO4dNFU&t=2s