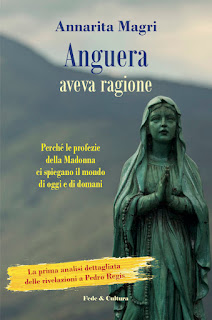"Crocifisso sul palo del telegrafo": Quasimodo e la violenza nel Novecento
Una delle poesie più note di Quasimodo, Alle fronde dei salici, recita:
E
come potevamo noi cantare
Con
il piede straniero
sopra il cuore,
Tra
i morti abbandonati nelle piazze
Sull’erba
dura di ghiaccio, al lamento
D'agnello dei fanciulli, all'urlo nero
Della
madre che andava incontro al figlio
Crocifisso sul palo del
telegrafo?
Alle
fronde dei salici, per voto,
anche
le nostre cetre erano
appese,
oscillavano lievi al triste vento. Questa poesia molto nota e tratta dalla raccolta Giorno dopo giorno, pubblicata nel 1947, è un valido esempio della poesia del secondo Quasimodo, quella che gli ha probabilmente attirato maggiori consensi e spianato la via al Nobel del 1958: al primitivo ermetismo, più arduo e che attinge a temi assoluti, mitici, il poeta unisce la riflessione sulla contemporaneità e sulla società del Dopoguerra. Qui però medita sulle devastazioni prodotte dall'invasione tedesca della Seconda Guerra Mondiale: e la lirica di Quasimodo densa di immagini, ma di immagini che risultano, in fin dei conti, semplici e senza tempo, evoca il dominio sprezzante del nemico (la metonimia con il piede straniero sopra il cuore) e le vittime delle sue atrocità in vario modo: i morti abbandonati nelle piazze, poi la metafora dell'agnello che si lamenta prima di essere condotto al macello ed è termine di paragone per i bambini, infine la forte sinestesia l'urlo nero /della madre che andava incontro al figlio / crocifisso sul palo del telegrafo. Quasimodo usa volutamente il vocabolo "crocifisso" per rimandare al motivo della crocifissione di Cristo; del resto, anche l'immagine dell'agnello rinvia a Lui (si legga la profezia di Isaia 53, 7, come un agnello condotto al macello... applicata a Lui; qui sotto la splendida resa nell'Agnus Dei di Francisco de Zurbaran, 1635-40).
Il filo unificante della poesia è costituito da un "pre-testo", cioè un testo che serve da modello e riferimento: il salmo 137, ovvero "salmo dell'esiliato" (qui vv. 1-4):
Sui fiumi di Babilonia,
là sedevamo piangendo
al ricordo di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
canzoni i nostri oppressori:
"Cantateci i canti di Sion!"
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Gli Ebrei portati in esilio a Babilonia dopo la sconfitta del 586 a.C. non possono più intonare i canti del Tempio distrutto di Gerusalemme e vengono scherniti dai loro carcerieri, che domandano loro proprio quei canti; così essi appendono ai salici (si noti, piangenti) le loro cetre, strumento tipico di accompagnamento del culto interrotto. Nella lirica di Quasimodo, la cetra rappresenta la poesia, muta davanti alle atrocità della guerra; e l'ultima, bellissima immagine dei versi è proprio quella delle cetre che dondolano tristemente al vento, un vento "triste" (ipallage). Quasimodo era molto sensibile al tema dell'esilio: qui è come se ritraesse la sua terra, l'Italia, in esilio da se stessa a causa di una crudele invasione. Che l'autore sia stato affascinato proprio dal "canto biblico dell'esiliato" è sintomatico.
Qui vorrei soffermarmi soprattutto sull'immagine, molto densa, del "figlio crocifisso sul palo del telegrafo", triste spettacolo di troppi massacri novecenteschi. Essa porta a compimento una specie di climax di immagini di morte. Il primo parallelo che mi viene in mente è un particolare di Guernica di Picasso, la celebre tela a olio in bianco e nero che rievoca la Guerra Civile spagnola e il terrificante bombardamento della Luftwaffe sull'omonima cittadina basca del 26 aprile 1937: un quadro volutamente brutto, per rappresentare le brutture del conflitto. Mi riferisco qui alla madre che regge il figlio bambino tra le braccia e si dispera, una versione cubista del motivo tradizionale della Pietà o della Madonna col Bambino.
Come nella lirica di Quasimodo, il riferimento al Cristo è implicito: Lui è la vittima per eccellenza a cui tutte le vittime innocenti sono assimilate. Lo stesso avviene in un altro celeberrimo quadro, anch'esso denuncia di una guerra insana, quella napoleonica d'invasione della Spagna del 1808: 3 maggio 1808 di Francisco Goya. Il quadro rappresenta, assieme al 2 maggio 1808, la resistenza madrilena contro i Francesi e le successive fucilazioni: sullo sfondo di una Madrid buia, un nucleo di fucilieri senza volto, si direbbe senz'anima, punta il fucile contro un gruppo inerme di ribelli. Già alcuni cadaveri sono riversi nel sangue a sinistra, ma tutta l'attenzione è attirata dal'unico punto bianco del quadro, un uomo ritratto volutamente con le braccia alzate come un Crocifisso e rivestito di una camicia bianca. Anch'egli è una vittima innocente che sta per morire. Il quadro fu realizzato nel 1814, dopo che le guerre napoleoniche erano ormai finite (salvo Waterloo).
Sempre Goya ha realizzato, con un anticipo strabiliante rispetto ai massacri del Novecento, una serie di stampe eseguite nel 1820, I disastri della guerra, in cui dettagliava gli orrori dell'invasione napoleonica. Una, terrificante, assomiglia proprio all'immagine offerta da Quasimodo:
Si noti il soldato francese che osserva l'impiccato, senza dar segni di sentimento alcuno, indifferente.
Purtroppo, però, di "crocifissi sul palo del telegrafo" nel corso del Novecento ce ne sono stati tanti: proprio i telegrafi, simbolo di modernità, sono divenuti spesso, troppo spesso, delle sinistre forche (del resto, già all'epoca della Repubblica romana, gli schiavi insorti con Spartaco erano stati crocifissi lungo tutta la via Appia). Qui sotto una foto che rappresenta corpi di partigiani uccisi ed esposti in pubblico a Ravenna nel 1944 a opera dei nazi-fascisti. E si ricorderà come la scena si ribaltò quando vennero uccisi Mussolini e i suoi. Al di là delle intenzioni dei partigiani, i corpi del Duce, della Petacci e di altri furono appesi alle filanie di Piazzale Loreto ed esposti al pubblico ludibrio come già era successo a tanti prima di loro.
Sotto invece una tristissima immagine del Viale dei Martiri di Bassano del Grappa, dove, il 26 settembre 1944 furono esposti i corpi di 31 giovani della Resistenza trucidati dai Tedeschi. Al ritorno da Berlino, alcuni dei miei allievi di 5O, tra cui Sofia, mi hanno mostrato delle foto analoghe di partecipanti della Resistenza ucraina impiccati ai pali del telegrafo al passaggio della Wehrmacht.
Ma non è tutto. La pessima abitudine di appendere i giustiziati ai pali del telegrafo come monito atroce per la popolazione si era già diffusa nel Messico devastato dalla guerra cristera, la rivolta scoppiata nel 1926 e terminata nel 1929, dopo che una legislazione violentemente anti-cattolica era stata imposta dall'élite governativa liberale al paese fin dal 1917, poi applicata con la forza nel 1926. Si noti che i fedeli messicani reagirono dapprincipio con la non violenza e solo dopo numerose vessazioni alcuni si diedero alla macchia ed alla resistenza armata. In una scena del bel film Cristiada, del 2012, che ripercorre le vicende della rivolta, un rappresentante della conferenza episcopale del Messico sta cercando di trattare su di un treno con l'ambasciatore americano (che rendeva possibile il rifornimento di armi al governo), per giungere al termine del conflitto. A un certo punto, il treno ha un sobbalzo e si ferma: dal finestrino è visibile una scena identica a quella fotografata qua sotto. Numerosissimi sacerdoti e laici fecero questa fine semplicemente perché erano cattolici. Si calcola che la guerra provocò tra i 70.000 e gli 85.000 morti: morti di cui nessuno parla mai...
Dato che ci sono inserisco qui il link del trailer del film, che annovera tra i suoi protagonisti Andy Garcia, Peter O'Toole ed Eva Longoria.